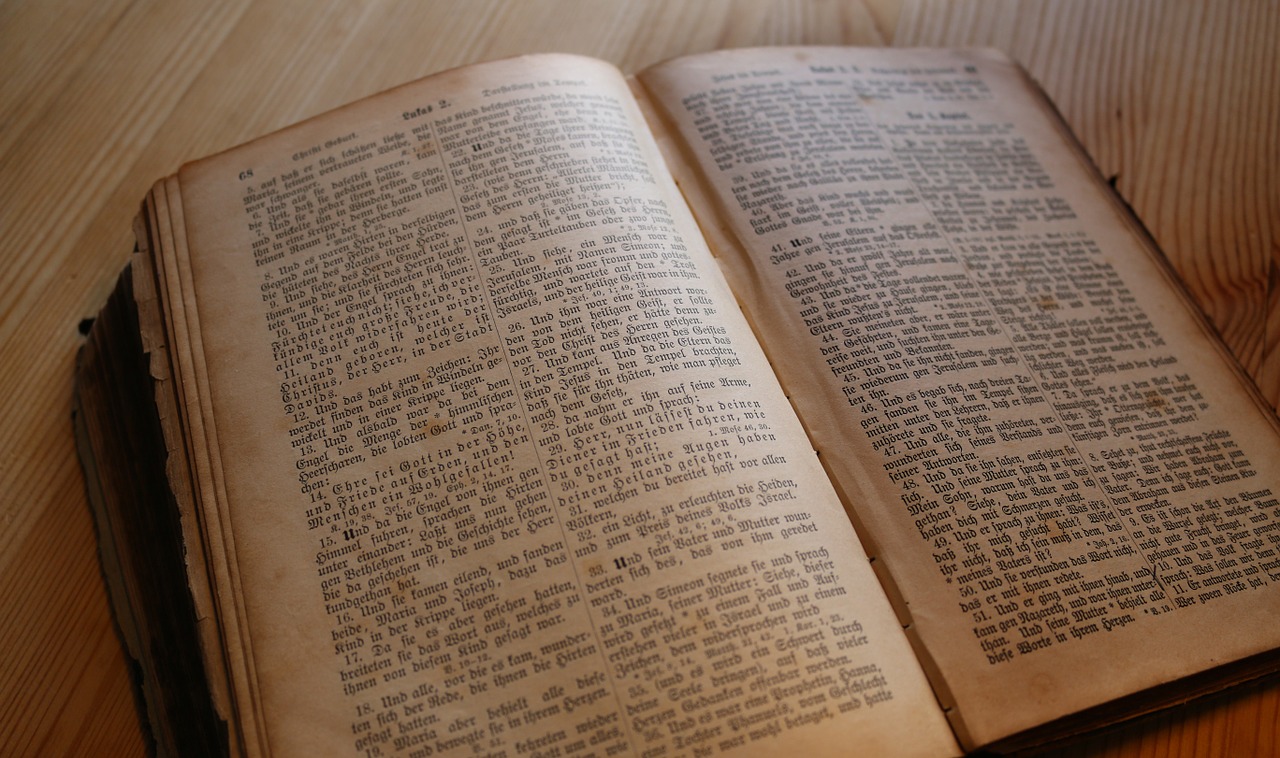
Inauguriamo la rubrica di approfondimenti riportando un articolo della rivista “il Regno” che tratta dell’intervento di Mons. Erio Castellucci al XV Convegno nazionale di Pastorale Giovanile tenutosi nel febbraio scorso.
Ringrazio tutti i presenti, i relatori, gli organizzatori e in particolare l’amico don Michele Falabretti, che mi ha benevolmente costretto a intervenire. Ho cercato di risparmiarvi questa prova, ma don Michele – approfittando anche della sua imponenza – è stato inflessibile. «Generare», il verbo che caratterizza questa riflessione, evoca una comunità, un atto d’amore e un passaggio doloroso per una gioia più grande. La generazione di una nuova vita è opera di un uomo e una donna, in «intima comunità di vita e di amore» che – come dice Gaudium et spes, n. 49 – caratterizza il matrimonio fecondo. In secondo luogo, generare è un atto d’amore: di sua natura, l’amore esce da se stesso, si apre al nuovo, dà vita, continua la creazione (pro-creazione). Infine, la generazione si compie attraverso un passaggio doloroso: doloroso per la donna che partorisce, per il bambino che non a caso entra nella vita umana piangendo e spesso anche per il padre, che sperimenta un senso d’impotenza davanti alla sofferenza della madre; ma si risolve poi in una grande gioia per tutti, perché una nuova vita quando arriva dà energia a chi la attendeva e crea una «rete magica» attorno al neonato.
Queste tre caratteristiche della generazione non riguardano solo la carne, ma anche la mente e lo spirito. Chi genera conoscenza, ad esempio insegnando, attinge al tesoro culturale di una comunità, compie un atto di amore consegnando ad altri le proprie idee ed esperienze e richiede
di superare, con l’applicazione e lo studio, le comode ristrettezze mentali, nell’apertura a conoscenze più vaste. Così chi genera «una vita di fede» – come recita il titolo – e quindi opera sul piano spirituale, lo fa trasmettendo un patrimonio comunitario che proviene dal Vangelo e dalla tradizione della Chiesa, lo fa per amore verso il Signore e le persone che gli sono affidate, e deve dosare sapientemente anche i no, le correzioni e i sacrifici, per poter annunciare il grande sì di Dio, che è Gesù.
L’atto generativo – fisico, mentale o spirituale che sia – ha di conseguenza tre nemici che lo rendono impossibile: l’isolamento, che si contrappone alla dimensione comunitaria; la paura e il pregiudizio, che si oppongono all’atto dell’amore; e la fretta di raggiungere il risultato, che si contrappone alla pazienza della «cura» e dell’«attesa», le due parole che danno il titolo a questo Convegno. Per entrare dunque direttamente in tema: un buon educatore dei giovani agisce a nome della comunità e non da solitario, è mosso dall’amore verso i ragazzi e non si fa prendere da paura e pregiudizio verso di loro, sa mettere i necessari «no» dentro al grande «sì» che è il Vangelo.
1. Educare i giovani: sport di squadra
Il primo fattore di sterilità nell’educazione dei giovani è quindi l’isolamento dell’educatore, che può nascere da una sorta di gelosia possessiva: quando un educatore dice «i miei ragazzi» e racchiude il suo gruppo dentro a una campana di vetro, diventa sterile, non genera vita di fede. Qualche volta questa gelosia si maschera da disponibilità a 360°, si nasconde dietro una generosità a tutto campo, si mimetizza sotto una grande intraprendenza e un attivismo continuo; ma in realtà è compensazione affettiva, bisogno di approvazione, narcisismo patologico. L’educatore- chioccia è un libero battitore, che toglie però la libertà ai ragazzi.
È vero che Gesù aveva «i suoi» (hoi idioi), come qualche volta Gv chiama i discepoli; ed è vero che lui usa degli aggettivi possessivi: «la mia Chiesa» (Mt 16,18), «le mie pecore» (cf. Gv 21,15-19), «miei discepoli» (Gv 13,35), e così via. Ma lui, appunto, è il Signore, ed è l’unico che può possedere dando, e non togliendo, vita e libertà. Infatti lascia sempre liberi: «se qualcuno vuole venire dietro a me»… (Lc 9,23); «anche voi volete andarvene?»
(Gv 6,67). Tutti gli altri educatori, che agiscono in suo nome, diventano usurpatori se dicono «miei» e non dicono «suoi».
È proprio trasmettendo a Pietro il compito di guida, che Gesù dice: la Chiesa da edificare è «mia», non tua; le pecore da pascere sono «mie», non tue. Ed è vero che Gesù stesso ha evocato l’immagine della chioccia, lamentandosi perché avrebbe voluto raccogliere i figli di Gerusalemme «come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali» e loro non hanno voluto (cf. Mt 23,37). Ma se Gesù vuole diventare chioccia, è solo per il tempo necessario a custodire la comunità e attrezzarla per la missione. È evidente nel brano sintetico di Mc 3,14: «Ne costituì dodici – che chiamò apostoli – perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni». Lui li «fece» proprio, cioè diede loro vita come in una nuova creazione; e li fece perché prima di tutto stessero con lui: ma non per gloriarsene o creare un gruppetto chiuso, bensì per inviarli a predicare e combattere il male.
La comunione è per la missione; è comunione generativa, non sterile, perché si apre al mondo. Del resto ogni volta che Gesù paragona se stesso a un pastore e i discepoli a un gregge – per riprendere un altro motivo ispiratore di questo convegno – non lo fa mai in modo intimistico, per creare un «cerchio» degli affetti, ma dice: «Ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare» (Gv 10,16). O, nella tradizione sinottica: «Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita?» (Mt 18,12; cf. Lc 15,4-6). Il gregge di Gesù è aperto, non è chiuso dentro gli steccati. Gesù piega l’immagine più intima che si possa pensare – quella dell’ovile – alle esigenze della missione. Si fa sempre notare come il verbo «educare» significhi «trarre fuori»: è vero, ma non solo nel senso di estrarre dalla persona le risorse che racchiude, bensì anche nel senso di condurre la persona fuori dal proprio cerchio, attrezzarla a camminare con le proprie gambe nella società.
Che cosa intendiamo per «comunità cristiana»?
L’educatore vince la gelosia possessiva quando si sente ed è mandato dalla comunità cristiana. Infatti non compie quel servizio a nome proprio, ma a nome della comunità, che è il soggetto educativo fondamentale. Ma perché questa affermazione non rimanga astratta o scritta nel libro dei sogni, è necessario precisare l’identità di questa comunità educante. Che cosa intendiamo con «comunità cristiana»? In un’assemblea presbiterale nella
mia diocesi di origine, Forlì-Bertinoro, alcuni anni fa si creò a un certo punto una certa confusione di linguaggi a proposito della comunità. Uno dei parroci propose agli altri di istituire nelle singole parrocchie la «messa comunitaria settimanale»; un altro rispose, interpretando il pensiero di mol ti, che esisteva già: era la messa domenicale. Ma il primo insistette, precisando: «Non mi riferisco alla messa rivolta a tutti, ma a quella, in un giorno feriale, a cui sono invitati gli operatori pastorali». Nacque un dibattito interessante sulla nozione di comunità. Mi sembra che la comunità cristiana possa essere intesa in tre modi. Cominciamo dalla nozione più ristretta, per andare gradualmente verso quelle più ampie.
Con il termine «comunità cristiana» si può intendere prima di tutto il gruppo degli operatori pastorali, ossia tutti coloro che svolgono qualche forma di servizio, in genere in una parrocchia. Quando un parroco pensa alla propria comunità, è possibile che la intenda in questo senso, come comunità ministeriale, che comprende tutte le persone impegnate nei vari ambiti della pastorale: dall’evangelizzazione e catechesi alla liturgia, dalla carità all’organizzazione, dal mantenimento delle strutture alla gestione dell’economia, dall’animazione della preghiera ai servizi più umili ma non meno preziosi.
In questo primo significato, la comunità che educa è costituita da tutti i collaboratori pastorali: anche i volontari del centro di ascolto o gli animatori della liturgia «educano» i giovani, pur senza avere un mandato diretto nei loro confronti. A questo livello occorre vincere una tentazione pastorale: l’apertura della caccia. La stagione venatoria, affidata alle regioni, si apre in genere a settembre, proprio come l’anno pastorale. E la specie più cacciata da tutti i gruppi è proprio quella dei giovani; fatto ancora più grave, se si pensa che in alcune zone appare come una specie in via di estinzione.
Tutti chiedono di inserire dei giovani tra le loro fila: dai soci della San Vincenzo al gruppo dei catechisti, dalle signore del rosario pomeridiano al coro parrocchiale. Il problema non consiste nel desiderio di mantenere il proprio gruppo – essendo gruppi di servizio, vanno a beneficio di tutti – ma nell’attività venatoria stessa. La pastorale non può diventare una campagna di arruolamento più o meno forzato. È piuttosto il gruppo dei giovani che, attraverso un discernimento guidato, intreccerà la sua attività con i diversi ambiti pastorali della comunità. L’AGESCI invia i ragazzi a fare servizio anche fuori dalla propria associazione, facendo in questo modo conoscere ai giovani altre esperienze ecclesiali o assistenziali e riportando poi nel gruppo scout la ricchezza delle esperienze vissute. Infine, a questo primo livello della comunità, è bene ricordare che i giovani devono avere voce in capitolo negli organismi parrocchiali e in primo luogo nel Consiglio pastorale parrocchiale, che non può solamente parlare dei giovani, ma deve anche ascoltare i giovani.
Se però avessimo chiesto ai cristiani dei primi secoli che cosa s’intende con «comunità cristiana », la risposta sarebbe stata più ampia rispetto al solo gruppo di collaboratori: l’appartenenza alla communitas era connotata dalla partecipazione alla communio eucaristica; e se in latino le due parole sono comunque distinte, pur avendo la stessa radice, in greco si tratta della stessa parola, koinonia, che designa sia la comunità ecclesiale sia la comunione eucaristica. Era infatti l’eucaristica a «cementare» la fraternità dei battezzati, in modo da trasformarli in vera e propria «comunità».
Anche questo secondo significato, più ampio del primo, è dunque pienamente legittimo ed è pure teologicamente più profondo e permette di vedere nella comunità eucaristica, più numerosa di quella ministeriale, il soggetto fondamentale della Chiesa, il motivo stesso per cui è definita ekklesia, cioè comunità convocata. La comunità eucaristica è una comunità educante, anche per i giovani; è la fonte e il culmine di tutta la vita e attività della Chiesa. Ma qualche volta diventa nei fatti, più che fonte, uno stagno. I giovani praticanti non sempre escono ravvivati nella fede dalle nostre liturgie eucaristiche. È chiaro che non possiamo trasformare la messa in una rappresentazione teatrale e nemmeno dimenticare che vi partecipano non solo ragazzi e giovani, ma anche bimbi, famiglie, adulti e anziani. Eppure qualche atto di fiducia nei giovani, anche osando, può aiutare: affidando loro qualche volta il canto, o le letture, o le intenzioni. E utilizzando nell’omelia un linguaggio che, senza essere volgare o giovanilistico – cosa che desterebbe il compatimento prima di tutto degli stessi giovani – eviti le derive paternalistiche, moralistiche o astratte e sia aderente alla realtà.
Esiste però una terza e ancora più vasta nozione di comunità cristiana: è la comunità battesimale, ossia l’insieme dei battezzati, compresi coloro che si preparano a ricevere il battesimo. Ancora prima che nascessero le parrocchie e venissero evangelizzati i villaggi (dal IV sec.), le comunità urbane consideravano sé stesse come l’insieme dei battezzati e dei battezzandi, attivando nelle case percorsi strutturati di catecumenato e incontri formativi di catechesi a partire dalle Scritture. Nel contesto della persecuzione anticristiana – che è ancora oggi il contesto di milioni di cristiani nel mondo – la comunità battesimale tendeva a identificarsi con la comunità eucaristica, perché si trattava di credenti molto motivati e quindi normalmente partecipi alla liturgia nel giorno del Signore. E tuttavia per vari motivi, già nei primi tre secoli, alcuni battezzati disertavano la cena del Signore, essendo ostacolati a parteciparvi direttamente per malattia, detenzione o timore della persecuzione.
Anche questo terzo e più vasto significato di «comunità cristiana» s’intreccia con la pastorale giovanile. Dall’epoca dei «giovani del muretto» fino a «Una luce nella notte», dall’evangelizzazione di strada alle «Sentinelle del mattino», sono tante le esperienze accumulate negli ultimi decenni nelle nostre diocesi. E tutte hanno sicuramente qualcosa da dire e da insegnare. Pensando soprattutto ai nostri gruppi o gruppetti parrocchiali, credo che l’attenzione al territorio costituisca ancora oggi un valore che la comunità cristiana custodisce. La parrocchia è normalmente sparsa su un territorio, con i suoi problemi e le sue risorse, con una determinata configurazione geografica (pianura, mare, collina, montagna, città) e sociale (quartiere popolare, campagna, zone industrializzate, centri storici e così via). Ogni parrocchia presenta quindi un volto specifico: e questo volto è anche un’opportunità missionaria.
La formazione di adolescenti e giovani deve essere attenta al territorio, e da lì ricevere stimoli e ispirazioni. Sappiamo bene che non è più il tempo della formazione intesa solo come catechesi e della catechesi intesa solo come esperienza di lettura e confronto attorno a un tavolo. Associazioni come l’Azione cattolica, già da decenni – in seguito al documento Il rinnovamento della catechesi del 1970 – hanno impostato la catechesi esperienziale, che annoda la teoria e la prassi, l’incontro e la riflessione, l’attività e il pensiero.
Se, come dice papa Francesco in Evangelii gaudium, nn. 231-233 – la realtà è più grande dell’idea, è tempo ormai di convertire la formazione in un circolo virtuoso tra attività pratica e riflessione teorica. Non dico nulla di nuovo: quando la formazione dei giovani, molti o pochi che siano, comporta esperienze di servizio sul territorio, specialmente in favore di persone bisognose e disagiate come i poveri, gli immigrati e gli ammalati; momenti di preghiera impostati dai giovani stessi, con l’aiuto degli educatori; attività di distensione e di svago (musica, teatro, cinema, canto, arte, sport, comunicazione); incontro con testimonianze vive di persone che possono comunicare esperienze significative di vita cristiana; momenti di fraternità e di festa… Quando gli ingredienti sono questi, non è sempre vero che i giovani spariscono, perché sperimentano che la comunità cristiana – ministeriale, eucaristica e battesimale – ha tanto da dare a loro e ricevere da loro.
2. Educare i giovani: «cosa di cuore»
La famosissima espressione che san Giovanni Bosco fissò in una lettera del 29 gennaio 1883, l’educazione è «cosa di cuore», svela il segreto fondamentale del rapporto educativo. «Cosa di cuore» non esclude lo studio di strategie, l’apporto delle indagini sociologiche, l’uso degli strumenti più adatti e più moderni. No: dice solo che tutto questo senza il «cuore» rimane vuoto. Il «cuore» indica la relazione tra educatori e ragazzi, un affetto che non sia possesso – come già osservato – e una cura che arrivi alla persona. «Cuore» è la parola che compone cordiale, coraggio; implica dunque ascolto cordiale del giovane, fiducia e incoraggiamento nei suoi confronti, anche davanti agli errori. Ma poiché mi devo concentrare sull’aspetto comunitario, vorrei notare prima di tutto
che il clima sociale nei confronti dei giovani è tutt’altro che «cordiale» e «incoraggiante». Quasi sempre quando si parla di giovani, purtroppo anche nelle nostre comunità, li si abbina a parole come «problema», «dramma», «disagio».
Per fare solo un esempio, leggo i titoli de Il Resto del carlino del 15 febbraio 2017: «Ragazzi suicidi, è allarme» (p. 1); «Generazione friabile» (editoriale, p. 1); «Basta genitori amici dei figli» (p. 3): «Giovane diciassettenne vittima del male oscuro» (p. 3); «Sul social il video hot della sedicenne» (p. 4); «Due ventenni accusati di violenza sessuale di gruppo» (cronaca locale, p. 3); «Adolescenti depressi» (cronaca locale, p. 5); «Lottiamo tutti contro il bullismo» (cronaca locale, p. 9); «Botte fuori dal liceo» (cronaca locale, p. 13). E tutto questo in una sola giornata. È la descrizione di una catastrofe: altro che incoraggiamento e «cuore».
Possiamo lasciare i giornali, che spesso devono fare notizia, e ricorrere ai pensatori. Uno scrive: «Ora (…) i giovani sentono il bisogno di distinguersi, e non trovando altra strada aperta come una volta, consumano le forze della loro giovanezza, e studiano tutte le arti, e gettano la salute del corpo, e si abbreviano la vita, non tanto per l’amor del piacere, quanto per esser notati e invidiati e vantarsi di vittorie vergognose, che tuttavia il mondo ora applaude, non restando a un giovane altra maniera, di far valere il suo corpo, e procacciarsene lode, che questa». Il linguaggio arcaico fa capire che non è un brano contemporaneo, ma le idee sono sempre quelle: i giovani di oggi sono peggiori di quelli di un tempo. È Giacomo Leopardi che, quasi due secoli fa, il 21 giugno 1820, annotava nel suo Zibaldone di pensieri le riflessioni citate. E in molti altri passi deplorava la condizione e la vita dei giovani «di oggi», peggiori a confronto delle generazioni passate. Un altro esempio: «Il costume del mondo è stato sempre di peggiorare, e che il futuro fosse peggiore del presente e del passato. Le generazioni migliori non sono quelle davanti, ma quelle dietro; e non c’è speranza che il mondo cambi costume» (10 novembre 1820). Lo stesso giorno scriveva: «Il giovane è incapace d’altra consolazione che della morte».
Un ultimo esempio. Un altro famoso autore contrappone la semplicità dell’antica sapienza alla filosofia del suo tempo e ragiona sulla differenza tra i giovani del passato e quelli del presente. Nelle scuole di oggi, dice, non c’è più interesse per gli studi e c’è una grande solitudine; la gioventù si accalca attorno a quelli che vivono in maniera dissipata, i ragazzini vengono sfruttati in tante maniere e appena diventano adolescenti si pettinano tutti allo stesso modo. Sembra di sentire i commenti dei docenti a un consiglio di classe delle medie, e invece è la Lettera 95 di Seneca, un testo che ha poco meno di duemila anni. Non escludo che si trovino riflessioni simili sui giovani di oggi, peggiori di quelli di una volta, in qualche papiro dell’antico Egitto.
Non vogliamo e non possiamo mettere la testa sotto la sabbia. Ma non possiamo e non vogliamo neppure accodarci al topos della corruzione dell’odierna gioventù. Ci sono tanti problemi, innumerevoli drammi, fatiche di ogni genere. Ma se l’educazione è «cosa di cuore», è prima di tutto la comunità cristiana nel suo insieme a dover reagire, incoraggiando i giovani e reagendo alla litania dell’indignazione generalizzata verso di loro.
Guardare i giovani senza precomprensioni
Durante il mio ministero di parroco a Forlì, alcuni anni fa, ebbi in proposito una piccola illuminazione interiore. A una riunione del Consiglio pastorale parrocchiale emersero dei fatti spiacevoli a carico di adolescenti che frequentavano la parrocchia: qualche episodio di bullismo e alcuni gesti di teppismo, tra cui il lancio di ghiaia dal giardino di casa contro i ciclisti che passavano per strada. Dedicammo una buona mezz’ora a disapprovare i comportamenti di questi ragazzi, che in parrocchia erano animatori dei più piccoli, aiuto-catechisti o scout. Anch’io feci volentieri circolare la mia dose di sdegno, tra i tanti «dove andremo a finire?», «i ragazzi di oggi sono vuoti», «non c’è da fidarsi delle famiglie», e così via.
Terminata la riunione, a letto continuavo a riflettere su quegli adolescenti. Il bullismo e il teppismo proprio non mi andavano giù, anche perché conoscevo bene loro e le loro famiglie. Ma poi mi venne in mente una scena che probabilmente avevo rimosso. Verso i 13/14 anni, la stessa età di quegli adolescenti, insieme ad alcuni coetanei non avevo trovato miglior passatempo, nei pomeriggi primaverili, di questo: ci nascondevamo dietro le siepi del giardino di casa mia, ci dotavamo di robuste fionde con grossi elastici e di «forcelle», cioè pezzi di ferro ripiegati a «U» – ottenuti con morsa, pinze e tenaglie – e lanciavamo questi proiettili ai malcapitati che passavano per strada in motore o in bicicletta. Ricordo che – non essendoci all’epoca il casco – oltre ad alcuni più fortunati che vennero colpiti alle gambe, ne prendemmo un paio al collo. Dopo alcuni giorni venimmo scoperti e ce la cavammo con una bella sgridata da mio padre. Vi ho fatto questa confidenza, prima di tutto perché dopo quarant’anni e più il crimine è entrato in prescrizione e quindi non sono più perseguibile (e in ogni caso non farei i nomi dei complici); e poi, soprattutto, per dire che da adulti a volte rileggiamo la nostra antica giovinezza con una precomprensione di tipo angelico e i giovani di oggi con una precomprensione di tipo diabolico.
Gli educatori dei giovani hanno il compito, da questo punto di vista, di iniettare nella comunità cristiana una visione più completa dei ragazzi, meno pregiudiziale, meno colpevolizzante. Non sono solo educatori da parte della comunità, ma anche educatori della comunità. È importante, come diciamo spesso, che faccia notizia anche il bene. Sarebbe un sogno che invece di dieci titoli allarmanti sul mondo giovanile, ce ne fossero altrettanti incoraggianti. E ce n’è davvero tanto di bene tra i ragazzi e giovani, ma molti adulti – specialmente quelli che vivono di ricordi e non di presente – non lo sanno; sono sopraffatti dalle notizie cattive, seguono il topos della corruzione dei giovani di oggi.
Forse, per concludere anche questo secondo punto, si può riflettere attorno a un quarto possibile significato di «comunità», che affianca i tre già esposti. Il quarto non riguarda la comunità cristiana ma quella civile, eppure ha una grande importanza anche per quella cristiana. La parrocchia, infatti, è delimitata da un territorio all’interno del quale non vi sono solo dei battezzati, ma – in moltissimi casi almeno – anche appartenenti ad altre religioni e culture e persino «sbattezzati», cioè persone che hanno abbandonato polemicamente la tradizione cristiana. Anche questi sono legati in qualche maniera alla comunità cristiana, se è vero che il Signore ha inviato i discepoli «a tutte le genti», senza distinzione.
I ragazzi e i giovani vanno aiutati a conoscere queste diverse culture, non per favorire il relativismo,ma per motivare ancora meglio la propria fede e accogliere il buono e il vero dovunque esso sia. Perché la fede nell’azione universale dello Spirito ci aiuta a vedere la sua presenza anche al di fuori dei confini visibili della Chiesa. Educare, condurre fuori, significa anche questo. Ma è vero anche l’inverso: attraverso questi incontri con gli «altri» e attraverso i servizi e le attività che i giovani cristiani possono avviare sul territorio – animazione, assistenza, feste, musica, doposcuola,sport, incontri e così via – anche coloro che non appartengono alla comunità cristiana sono aiutati al dialogo e all’apprezzamento della nostra tradizione. Attraverso i giovani si costruiscono più spontaneamente quei ponti che aiutano a buttare giù i muri e vivere nel rispetto reciproco.
3. Educare i giovani: allenarli ad amare il sentiero
Una delle chiavi della gioia è l’amore per il sentiero. A volte, invece, coltiviamo l’amore per la meta detestando il sentiero. È vero che un sentiero senza meta non è amabile, anzi, rende la vita un vagabondaggio. Ma è anche vero che cercare di raggiungere la meta senza apprezzare il cammino è pesante, rende la vita un affanno. L’educatore è colui che accompagna il cammino, ne fa apprezzare la bellezza, attira lo sguardo sulle piccole
cose della strada. Sa qual è la meta, ma aiuta il giovane a non bruciarla, a guadagnarla poco alla volta.
È molto nota, ma la cito ugualmente, la brevissima pagina del Piccolo principe di Saint-Exupéry (c. XXIII) che parla della sete. «Buon giorno», disse il piccolo principe. «Buon giorno», disse il mercante. Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. «Perché vendi questa roba?» disse il piccolo principe. «È una grossa economia di tempo», disse il mercante. «Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano 53 minuti la settimana». «E che cosa se ne fa di questi 53 minuti?». «Se ne fa quel che si vuole…». «Io», disse il piccolo principe, «se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio adagio verso una fontana…».
Come nel parto, così nella crescita il travaglio del cammino e la gioia della meta sono sempre mescolati: non c’è l’uno senza l’altra. Quando andavo in route di strada con gli scout, qualche volta, insieme ai capi, mi spendevo nel motivare il significato del sentiero. Sul piede di partenza, dovendo iniziare un cammino di ore magari in buona parte in salita, di solito impostavo così la mia esortazione: vedete quella cima? Non è la stessa cosa raggiungerla a piedi, sudando e faticando, o arrivarci in seggiovia freschi e riposati. Se ce la sudiamo, sarà nostra, la gusteremo di più. Non li ho mai convinti, ma credo sia proprio così.
L’educatore non fa l’errore di sedersi alla meta, indicando dall’alto al giovane quali passi compiere, come evitare di finire fuori strada, come rialzarsi; no: l’educatore cammina a fianco dei ragazzi, tiene il loro passo, li incoraggia e li aiuta a leggere il senso del cammino, valorizzando anche la fatica. E raccontando anche la sua fatica. È un atto educativo anche la comunicazione delle proprie difficoltà, dei propri fallimenti e dubbi, purché sempre in chiave positiva, di tensione verso la meta.
I ragazzi hanno bisogno di sentire che i loro educatori non sono dei supereroi, ma donne e uomini che credono nella meta, nel Vangelo di Gesù, e pur faticando cercano di raggiungerla. In qualche esperienza giovanile si è diffusa una pratica molto interessante: ciascuno, a un certo punto, sceglie la figura di un santo e legge la sua vita, raccontandola poi agli altri e spiegando perché l’ha scelto. Così i ragazzi imparano a smantellare il piedistallo su cui in genere si colloca il santo e magari anche a togliere l’aureola; imparano che è uno come loro, che ha fatto le sue fatiche nel sentiero, ma l’ha percorso con fedeltà ed è arrivato alla meta. E soprattutto allargano la loro idea
di comunità, perché fanno un’esperienza intergenerazionale, evitando l’appiattimento sull’oggi e scoprendo, da questo punto di vista, che la Chiesa ha una bella «tradizione».
Sarebbe molto facile adottare con i giovani una pastorale degli scacchi: bianco o nero, giusto o sbagliato, regolare o irregolare. È la pastorale statica, che risponde alla categoria dello spazio, dove la preoccupazione è di collocare, classificare, giudicare. Questa pastorale, che si sostiene solo sulle regole e sui divieti, non tiene più, se pure avesse mai tenuto. Papa Francesco, in Evangelii gaudium, nn. 222-225, ricorda che il tempo è superiore allo spazio. Non dunque gli scacchi, ma semmai il gioco dell’oca, capostipite dei giochi di percorso, è la metafora della pastorale dinamica, che risponde alla categoria del tempo, che mette in cammino le persone. I giovani non devono essere classificati ma accolti e accompagnati.
Concludo con altre due immagini, che riguardano gli educatori. Non sono fotografi, ma registi. Il fotografo mira all’istantanea, blocca la situazione di un momento e la immortala. La tentazione del fotografo è presente in ogni educatore, perché è facile scattare un’istantanea e definire il ragazzo, associandogli dei comodi aggettivi, classificandolo entro qualche categoria. È facile dire di un giovane che è svogliato o fallito, ma anche definirlo genio o campione. In tutti i casi, quando si pretende che una fotografia dica la persona e la si incornicia, si cade nel giudizio e si impoverisce il mistero della persona.
Nessuno si può racchiudere dentro a un aggettivo, perché nessuno si identifica con una sua qualità o un suo difetto, con una sua azione o una sua affermazione. Il mistero della persona è molto più grande di ogni sua singola manifestazione. Per questo l’educatore è un regista: uno che accompagna la crescita dei personaggi, ne favorisce lo sviluppo, li porta dentro a una trama che va verso una conclusione. La vita non è una foto, ma un film: e i ragazzi sono per eccellenza coloro che possono cambiare, evolvere, maturare. Guai fissare un solo momento e dire: «È lui». Possiamo solo, come registi, accompagnare lo sviluppo e dire: «Può ancora camminare».
L’ultima immagine è quella del medico. L’educatore non è un giudice, ma un medico. Il giudice indaga, percorre le piste dei sospetti, emette sentenze. Ma Gesù non emette mai sentenze definitive: nel suo vocabolario non esiste la parola «spacciato». Gesù è medico – e lo dice lui stesso – ed è venuto per i malati, non per i sani (cf. Mt 9,12). I medici di un tempo – qualche volta anche quelli di oggi – ascoltavano il paziente, toccavano il corpo e poi curavano. Sono le tre azioni che compie Gesù con i malati: avvia un dialogo – «Che cosa vuoi che io faccia per te?» (cf. ad esempio Lc 18,41); poi normalmente tocca la parte malata del corpo, rimanendone – tra l’altro – contaminato per la mentalità del tempo; infine procede alla guarigione.
L’educatore è medico: prima di tutto ascolta il giovane. È un’opera inestimabile, di valore pastorale immenso. Chi ascolta i giovani oggi? Tutti devono parlare ai giovani, per ottenere magari di farseli clienti; ma chi perde tempo con loro nell’ascoltarli? Ascoltare un giovane significa già trasmettere un messaggio terapeutico: «Tu meriti questo mio tempo, tu sei importante per me». Il secondo gesto è toccare il corpo. L’educatore che abbraccia, dà una carezza o una pacca sulla spalla, trasmette quell’affetto che aiuta il giovane a camminare. Il corpo dei ragazzi è un vaso d’argilla, fragilissimo e problematico, ferito ma desideroso di affermarsi. Il contatto con il corpo rafforza nel ragazzo la serenità nei confronti di se stesso, lo fa sentire accolto.
Infine la cura, che può essere una medicina, la disinfezione di una ferita o addirittura un intervento chirurgico. Perché occorrono anche i «no», nella relazione educativa, ma deve essere chiaro che sono «no» medicinali, tesi alla guarigione. Anche quando il «no» fosse così forte da mirare all’amputazione di un’abitudine dannosa o di un comportamento scorretto, dovrà sempre risuonare dentro a un «sì» molto più grande. I «no» che fanno crescere sono quelli pronunciati da un educatore che ama, s’interessa, si appassiona alla situazione del ragazzo, al punto da correggerlo. Io accetto una correzione da una persona che mi ama, la respingo da una che esprime solo la sua rabbia.
Ma per essere registi e medici aggiornati e capaci è necessario lavorare in équipe, altrimenti non si rimane al passo con i tempi. Per questo è l’équipe degli educatori il soggetto che concretamente porta avanti la pastorale giovanile, e non il singolo educatore. Anche lui, infatti, ha necessità di confrontarsi, sfogarsi e condividere gioie e fatiche. Gesù lavorava in équipe: il servizio educativo compie un salto di qualità quando passa dalla prima persona singolare alla prima persona plurale.
✠ Erio Castellucci,
arcivescovo di Modena-Nonantola
da “Il Regno”: ERIO CASTELLUCCI, Generare una vita di fede, Il regno/Documenti 2017/9, pp.284-290

